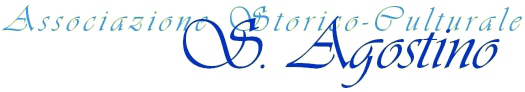Contenuto
Percorso : HOME > Iconografia > Cicli > Seicento > Italia > MondolfoCICLo AGOSTINIANo nel Chiostro di Mondolfo

Agostino sconfigge le eresie
MAESTRO DI MONDOLFO
1650-1670
Agostino sconfigge le eresie
Agostino sconfigge le eresie
La lunetta presenta un dipinto alquanto lacunoso di cui si legge a malapena la dicitura esplicativa, a sua volta incompleta, che recita cosý: NE PROPRI LACCII INCATENATA ...REME DELLA GRAN MADRE IL P... LANGUE PR... ORGOGLIO ... D'INFIDE SQUADRE PIU' D'UN HID.....
La figura di Agostino Ŕ andata persa dal busto in su e rimane ora solo la parte inferiore, da cui si deduce che il pittore l'ha dipinto nella sua dignitÓ di vescovo, pur non trascurando la sua identificazione con l'ardine agostiniano dato che indossa sotto il piviale la tunica nera.
Al suo fianco sinistro si erge un piccolo angioletto che regge con la mani il bastone pastorale. Sotto i piedi del santo giacciono due personaggi, che vengono schiacciata dall'imponente figura di Agostino. Questa posizione Ŕ tipica nella iconografia agostiniana per raffigurare gli eretici, che sono stati sconfitti dalle argomentazioni di Agostino.
Il santo sentý profondamente la necessitÓ di difendere l'ortodossia cristiana dalle eresie che imperversavano nel suo secolo. Nel corso della polemica contro i manichei e la loro visione dualistica dell'universo Agostino tende a sottolineare la bontÓ della creazione, la trascendenza di Dio e la superioritÓ dello spirito sulla carne. Nei confronti del donatismo Agostino sostenne che la Chiesa Ŕ un insieme di fedeli visibile, composta sia di santi che di peccatori. L'efficacia dei sacramenti non dipende dalla moralitÓ di chi li amministra, ma dalla grazia di Dio che opera attraverso di loro. In disaccordo con Pelagio, che predicava la capacitÓ dell'uomo di produrre e di scegliere il bene (di salvarsi pertanto usando le sue sole forze) Agostino ribadisce la realtÓ del peccato originale e pertanto l'urgenza della grazia divina per ottenere la salvezza (De natura et gratia).
Nell'anno 416 Agostino tratta la questione pelagiana. La fine della controversia donatista coincise pressappoco con l'inizio di una nuova disputa teologica che impegn˛ Agostino fino alla sua morte. L'Africa, dove Pelagio ed il suo discepolo Celestio si erano rifugiati dopo il sacco di Roma da parte di Alarico, era diventata il principale centro di diffusione del movimento pelagiano. GiÓ nel 412 un concilio tenuto a Cartagine aveva condannato i Pelagiani per le loro opinioni sulla dottrina del peccato originale, ma, grazie all'attivismo di Agostino, la condanna dei Pelagiani, che avevano avuto il sopravvento in un sinodo tenuto a Diospolis in Palestina, fu reiterata dai successivi concili tenuti a Cartagine e a Milevi. Un secondo periodo di attivismo pelagiano si svilupp˛ a Roma; papa Zosimo, dopo essere stato convinto da Agostino, nel 418 pronunci˛ una solenne condanna contro i Pelagiani.